
Quando si dice “Islam” la prima cosa che viene in mente è l’harem. Inutile nascondersi: chi non ha mai pensato a un luogo chiuso ma opulento, magnifico, dal lusso quasi inimmaginabile, pieno di donne stupende e velate, (qualche volta persino seminude) e sottomesse a un unico padrone, emiro o sultano poco importa.
Immagine dalla forte carica misteriosa ed erotica, l’harem, in parte, se lo è costruito l’Occidente. O meglio, l’orientalismo, che di questi stereotipi vive ancora.
Come non ricordare i quadri di Jean-August Ingres, come “La Grande Odalisca” (1814) o “Il Bagno Turco” (1862). Osservate bene i soggetti di entrambi i quadri. Cosa notate? Donne praticamente nude, corpi vicini uno all’altro, espressioni languide e lussuriose. Sembra proprio che le figure femminili dipinte non abbiano una vita molto stressante.
Vengono rappresentate come donne traboccanti voluttà, concentrare solo sulla cura del corpo e l’attesa del loro signore. Che noia mortale! In realtà, come sempre accade quando si vedono le cose da una sola prospettiva, quella che più fa comodo per un motivo o per un altro, svuotando di significato concetti, luoghi e avvenimenti storici, la situazione è un po’ diversa. Negli harem, infatti, le donne mai si sono sognate di girare nude e il bagno non fa eccezione, visto che un notevole del pudore era proprio anche delle donne chiuse nei ginecei.
Di più: mogli e concubine non dedicavano certo il loro tempo ad azioni peccaminose e lo stesso Ingres, non c’è ombra di dubbio, non ha mai visitato un harem.
Cosa vuol dire, poi, questa parola che, ogni tanto, viene usata a sproposito?
Harem viene dalla radice hrm, che indica ciò che è inviolabile, sacro, proibito. Infatti l’harem è proprio la parte della casa vietata non solo agli uomini (tranne, ovviamente il padrone di casa), ma agli estranei.
Il motivo è semplice: si tratta di un luogo riservato alla famiglia dell’uomo, dunque non solo alle mogli, ma anche alle sorelle, per esempio, o ai figli.
L’harem era gerarchicamente strutturato, ognuno aveva un compito ben preciso e molto spesso le donne che lo abitavano erano poche (solo grandi sovrani potevano permettersi ginecei con centinaia di donne).
Luogo inaccessibile, da cui è impossibile sia entrare che uscire.
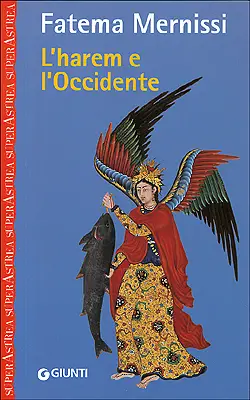 Frasi del genere se ne sono sentite e lette, eccome, ma non corrispondono, nemmeno in questo caso, alla verità: le donne potevano uscire dall’harem per un tempo limitato e velate, certo, ma generalmente non erano segregate. L’harem, dunque, non deve essere concepito come una sorta di misterioso antro dei piaceri, ma come il posto in cui viveva, separata dall’esterno, la famiglia. Ciò che sta nell’harem fa parte della vita privata, quel che ne sta al di fuori della vita pubblica.
Frasi del genere se ne sono sentite e lette, eccome, ma non corrispondono, nemmeno in questo caso, alla verità: le donne potevano uscire dall’harem per un tempo limitato e velate, certo, ma generalmente non erano segregate. L’harem, dunque, non deve essere concepito come una sorta di misterioso antro dei piaceri, ma come il posto in cui viveva, separata dall’esterno, la famiglia. Ciò che sta nell’harem fa parte della vita privata, quel che ne sta al di fuori della vita pubblica.
Di solito, inoltre, erano le donne delle classi colte a potersi permettere di rimanere in casa. Tutte le altre dovevano uscire per procurarsi di che vivere, al punto che trascorrere in casa le giornate era divenuta esclusiva prerogativa dei ceti agiati non solo musulmani, ma anche ebrei. Un’autrice araba famosa in Occidente ha ben spiegato cosa sia stato per lei l’harem, dal momento che proprio lì è venuta al mondo: Fatima Mernissi nei sui libri “L’Harem e l’Occidente” (Giunti, 2000) e “La Terrazza Proibita” (Giunti, 1999). A proposito del modo in cui i pittori occidentali immaginano l’harem, infatti, la Mernissi scrive: «… I loro harem dipinti, al contrario di quelli musulmani, non parlano di guerra tra i sessi, con le donne che resistono, mandano in aria i piani degli uomini e a volte diventano padrone del gioco, confondendo califfi e imperatori …». (L’harem e l’Occidente, ed. 2009 pag.23).
Francesca Rossi