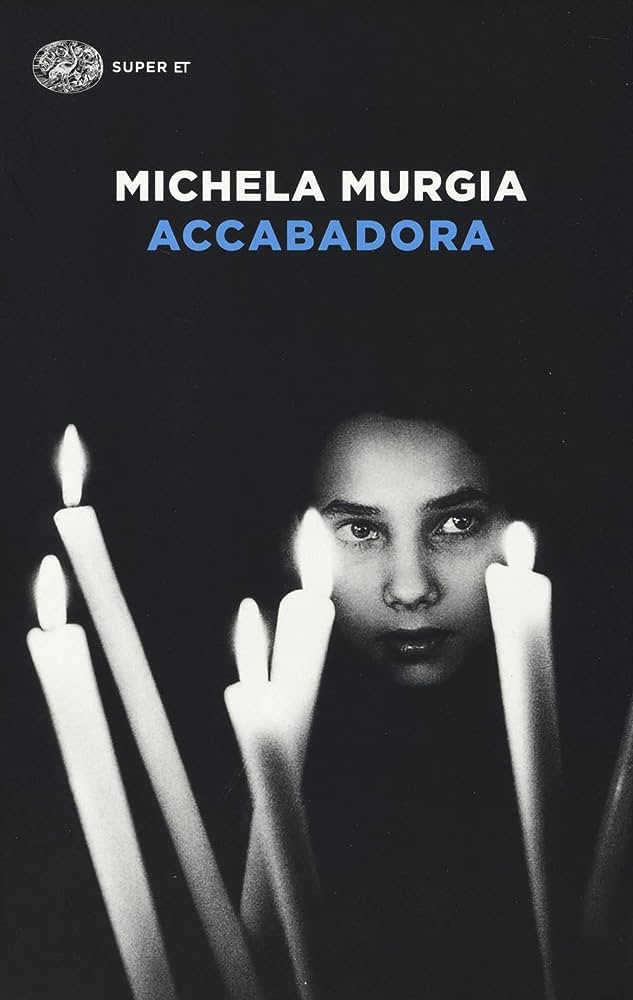“L’anima itinerante si appaga dell’altrove: natura, persona, luogo della mente. Ma talvolta si tratta del bordo di un precipizio: l’artista costeggia il vuoto originario”
e lo trasforma in arte.
Odio il carpe diem: mi risveglia il rimorso di non aver tentato, di aver sottratto a qualcuno un bene che non mi apparteneva, mi evoca il rimpianto di amori che altri non concede, il senso della colpa di vivere l’inerzia.
Ti odio carpe diem, perché mi distogli dall’oblio, ripetendo che la gioia superflua e passeggera è necessaria più del necessario, costringendomi a essere allertata in ogni istante, per poi continuare a suggerirmi, ma in tono più dimesso, che il mio destino coincide con la morte. Eppure ti ho stimato per tutta la mia vita e ora, nell’attimo in cui, chissà dove, è nato il coraggio del ripudio, mi accorgo tuttavia, con estrema meraviglia per la mia contraddizione, che il monito di non dimenticare mai la brevità dell’esistenza possiede una bellezza che, simile alla punta di un prezioso diamante, si incide per sempre sulla pelle. Carpe diem, perentorio e scolpito sulla pietra del tempo, abbraccia, con una sintesi incredibile, un tumulto emotivo e mentale che altrimenti deborderebbe dalla linearità necessaria alla scrittura.
Ma cosa esiste prima che la scrittura si formi e si conformi? Come nasce il pensiero creativo e, poi, il suo dirsi?
Dopo lunga gestazione nel conflitto con la norma – la bizzarra stravaganza di poter cambiare il mondo – il desiderio compie un passo oltre il consueto e, se il coraggio approva il gesto, un leggero movimento interno al petto, che non potrebbe avere ancora il nome di emozione per il gran silenzio che lo guida, chiede di essere ascoltato. Qui occorre fermarsi e ascoltare.
Nel buio della mente una intermittente lanterna, simile al mistero di una lucciola di sera, si accende ora qua ora là, vagante nei boschi intricati dei neuroni, assimilandosi al sottobosco piuttosto che alle alte e nere cime del mondo dell’inconscio. Qui risiedono, tranquille, memorie di impressioni, informazioni apprese in altro tempo, iperinclusività degli elementi, eccentricità dubbiosa di una strana malattia: affidare gli affetti alla scrittura, cedere all’inerzia dell’ozio imposto al corpo, superare se stessi ogni volta che il peso del confine impone sacrificio, la speranza che il tempo non ci espropri ogni possesso: una moltitudine di pluralità che agiscono in contemporanea rende difficile la scelta. Si spegne a questo punto la lucciola-lanterna, dopo essersi impregnata degli umori dell’ambiente e, al suo posto, lascia un desiderio di visione, che vorrebbe arrecare amore ad una vita. S’incanala nelle difficili vie dell’inconsapevole e contraddittoria volontà del dire – non saprei chiamare altrimenti quella forza che invade all’improvviso tutta la persona – in cerca di direzioni ipotetiche, intraviste e poi smarrite, guidata dall’insistente convincimento di momentanee, ossessive e maniacali verità, per far posto poi, in breve, all’armonia che nasce sopra al foglio. Termina qui la lotta della scelta. Nasce la scrittura. Vera, sicura e duratura. E’ da questo processo, quasi malattia, che si forma, dentro, l’apparire. La mano scrive e ogni allusione di affetti personali viene esclusa. Nasce sul foglio quello che non si prevedeva. Ma esiste l’intenzione?
E qui arrivo al limite del dire: dove nasce il linguaggio che contiene verità? Attraversando il corpo del dolore, che, discreto, non batte troppo spesso alla sua porta – ma, talvolta, è necessario che lo faccia – il desiderio, diffondendosi come vapore silenzioso nel corpo che lo nutre e incarnandosi con esso, senza danneggiare il contesto in cui risiede, si depura dalle scorie dell’identità di una persona. Aspetta tranquillo la sua disinibizione un po’ deviante. Qui sosta il tempo necessario per essere linguaggio.
Ma questa mia emozione, che sembra appartenermi, è mia, proprio mia, come anche, credo, è mio questo linguaggio? O si tratta di qualcosa che trascende la singola persona, utilizzando forse solo la porta spalancata che gli offro, per imprimersi leggero sul medio che l’aspetta? La mia composizione, costruita anche col mio impegno, è forse imparentata a una chimica scontrosa o all’influenza atavica, dovuta a un sistema dei miei geni, ed io non mi esprimo in nessun ruolo?
E qui cede volentieri l’Ego, ansioso di indagare di fronte a questa forza sconosciuta e le sussurra che è pronto anche per lui il tempo giusto alla visione. Nasce così questa scrittura, nascosta nella carne del mio corpo, ed io sono obbligata, dall’etica di esistere comunque in questo medio – io e altro insieme a me – a registrare, con la precisione di un occhio spalancato sulla lente di uno specchio piantato nel cervello, tutto ciò che vedo, finché arriva l’istante della fine e il movimento che distrugge è pronto a intervenire: il desiderio sparisce nella densità ombrosa e senza nome. Io mi sento privata, di nuovo, dell’amore. E’ così che il mio complesso turbamento muore, lasciandomi la pace che segue al desiderio, coinvolgendomi, infine, nel dono della prima conoscenza. Comincio pertanto a leggere e a capire ciò che è rimasto sconosciuto fino a questo istante. Ormai possiedo la scrittura. Si assesta, nel mio dentro, la sostanza indistinguibile e straniera. Qui potrebbe restare all’infinito, vita dopo vita, incapace di trasmettere visione ed apparenza, per poi ripresentarsi in altre vesti, senza alcuna parentela con la scrittura precedente. Forse è così che ciascuno di noi, come insiste la voce dell’Oriente, ritornerà un giorno di un nuovo tempo, che gli struttura eventi e situazioni, iniziando un’esistenza sconosciuta, fondata sull’oblio di quella precedente.
La scienza, a questo punto, vorrebbe intervenire, per impormi misura ed evidenza. Imporre il suo silenzio a ciò che potrebbe sembrare poesia. Ma la voce che mi guida nel processo continua a ripetermi che anche semplici parole possono far dono del privilegio di scoprire qualche cosa, piccole singolarità altrimenti taciute. L’amore che comanda queste cose è del genere primario, che non ti abbandona per altra scelta, né ti spezza per sopraggiunte necessità di vita non previste. Unico, ti salva nei momenti in cui l’anima, accecata dalla dispersione dell’istinto, vorrebbe cedere alla stanchezza del suo esistere. Esso ti accompagna, senza imporre alla tua anima il colpevole divieto dell’amore, fino a quando, contaminato dalla cecità sopravveniente nel tuo sguardo, sceglie di dileguarsi nell’impaludamento del non senso.
Pina Arfè